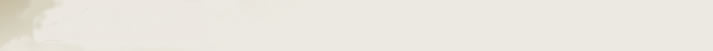Cerimonia di Premiazione della 19° Edizione del Concorso Nazionale di poesia e narrativa “Vittorio Alfieri”
organizzato dall’Associazione culturale di Volontariato ONLUS: “La poesia salva la vita”
Hanno partecipato al concorso 230 autori provenienti da molte Regioni d’Italia ed anche dall’Estero.
La giuria formata da docenti ed esperti qualificati.
Si è riunita per deliberare in merito alle valutazioni scaturite dall’esame dei testi partecipanti, giovedi – 10 Settembre 2020 ore 10. E dopo attento esame e valutazione dei tantissimi testi pervenuti. ha deliberato in maniera concorde premiando autori ed opere degne di merito e menzione. La giuria formata da:
Presidente Prof. Davide Ghezzo docente di materie letterarie e latino nei licei, e di scrittura giornalistica per l’università. Ha pubblicato una ventina di volumi tra narrativa, saggistica, poesia e antologie e manuali scolastici, attinenti la modalità fantastica della letteratura, conseguendo numerosi premi e riconoscimenti. Tiene incontri e conferenze sulle tematiche dell’insolito e della spiritualità.
Prof. Claudio Calzone Da sempre appassionato di poesia, storia, musica e letteratura fantastica, Ha pubblicato vari libri di poesie: romanzi e racconti, ha partecipato con un lungo racconto. Tiene conferenze su temi letterari, storici ed esoterici.
Prof. Antonio Lepore – Laureato in lettere moderne, è docente di materie letterarie presso l’istituto Superiore: “A. Castrignanò” di Asti, è docente di letteratura italiana presso l’Università delle tre età di Asti. Giornalista, pubblicista, ha scritto per periodici e riviste specializzate d’arte e letteratura, è autore di libri di poesia, di critica letteraria e d’arte, è direttore editoriale di spettAttore.
Andrea Laiolo – laureato a Torino in Storia del teatro esordisce come poeta con una silloge che vince il premio “Mario Pannunzio” nel 2005. Da allora ha pubblicato varie raccolte poetiche ed opere drammaturgiche. Ha collaborato ad una incisione di musica antica, inoltre si occupa dal 2008 di eventi teatrali e letture poetiche.
Prof. Michele Bonavero – Esperto conoscitore della cultura piemontese, attento alla cura della grafia, docente alla Università delle tre età di Torino.
Ed ecco i vincitori:
La sez. poesia in lingua italiana
4° – classificato – G. Luigi De Marchi di Torino con la poesia : “Notte”
4° – classificato – Ivo Brandi da Ascoli Piceno con la poesia: “maltrattato amore”
4° – classificato – Falbo Roberto da Catanzaro con la poesia : “Catabasi”
4° – classificato – Nicolina Ros da Pordenone con la poesia : “Hevrin Khalaf”
4° – classificato – Francesco Maria Mosconi da Ivrea con la poesia: “ Ospedale psichiatrico”
4° – classificato – Massimo Mezzetti da Roma con la poesia : “A piedi nudi”
4° – classificato – Blasi Fiore di Roma con la poesia : Roma nord
3° classificato – Salvatore Avellino da Foligno con la poesia: “O Virùs”
Motivazione: Coi toni coloriti del dialetto la poesia ci descrive l’epidemia nella sua forza annientante. L’espressività dialettale, di gusto quasi popolare, rafforza un pathos semplice e diretto e riscatta il difficile tema da ogni facile retorica, con un toccante abbandono alla fatalità e al disegno divino.
O virùs
Antrasatto nu bello juorno
ntra capa e cuollo na tempesta:
nu “virùs” a na luntana terra!
Accummenzaje o cuncerto de sirene,
sempe de pressa, notte e jorno;
diece, ciente, mille viècchie
cu dulore chiurene ll’uocchie,
senza lacreme, senz’accumpagne;
ll’urdeme viaggio senza niente,
forze cu na speranza sulamente.
E canta ancora na sirena
ma a voce è sempe a stessa:
è n’ata anema ca se ne và
forze cu nu penziero arriva llà!
Sulo Dio sa sta storia quann fenesce.
O cuorpo abbassa na buatta e cennere
Forze pe ce ricuedà: “Memento homo”.
Traduzione:
Il Virus
All’improvviso un bel giorno
tra capo e collo una tempesta:
un “virus” da una terra lontana!
Iniziò il concerto delle sirene,
sempre in fretta, notte e giorno;
dieci, cento, mille vecchi
con dolore chiudono gli occhi,
senza lacrime, senza accompagno.
E canta ancora una sirena
Ma la voce è sempre la stessa:
è un’altra anima che se ne va
forse con un pensiero arriva lì!
Solo Dio sa quando finisce questa storia.
Per il corpo basta un’urnetta di cenere
forse per ricordarci: “Memento homo”
2° classificato – Iemmi Marco da Varese con la poesia: “Andolla”
Motivazione: Opera che scorre fluida nel canto degli endecasillabi sciolti, a rispecchiare la serenità di un ambiente montano, scenario di un’escursione pronta a catturare immagini e quasi fotogrammi di uno spazio perfettamente estraneo alle brutture, agli stress, alle compulsioni del vivere cittadino.
Andolla
Fissato in fondo agli occhi in verd’essenza
Il mistico del Lago dei Cavalli.
La brezza m’accarezza l’esistenza
e libera la mente ed i pensieri.
Saluti tra i compagni di cammino.
I primi raggi sfrisano le fronde
dei larici, dei pini, degli abeti.
Melodiche campane in lontananza,
si fondono al frusciare dei ruscelli.
Pastori con le gerle stan salendo,
si fermano un momento… sorge l’alba.
Riflessi rosa scaldano il ghiacciaio.
Profumo dello strame ad essiccare,
canzoni di montagna nei torrenti.
La sassaiola attende il mio bastone,
in cima vedo il Passo dell’Andolla.
Rumori di richiami dal rifugio,
incontro arrampicando uno stambecco.
Il vento che accarezza lo scenario,
rimanda effluvi di fiori di campo,
d’alpeggio, di campanule e genziane,
di stelle alpine nate tra le rocce.
1° classificato – Vittorio Di Ruocco da Salerno con la poesia:
“Tornerò a cercarti tra le foglie”
Motivazione: Narrazione eloquente, condotta su un ritmo severo e costante di endecasillabi, di una sequenza di stati d’animo che si fondono con lo scenario naturale, in una smorzata luce crepuscolare, e nella scansione dolorosa e rassegnata di passato e presente, con un’armonia pacata che si distende sui tempi sospesi dell’incomunicabilità, ma balugina anche di elegiaca speranza.
Tornerò a cercarti tra le foglie
Nell’ora prepotente dell’obblio
io tornerò a cercarti tra le foglie
tra i petali fiammanti di un roveto
tremulo come l’aria che s’infuoca.
Certo raggelerai al mio cospetto
quando ti porterò scarno e impietrito
il mio più imperscrutabile sorriso.
Ti chiederai se il vento di una notte
potè cambiare a un tratto il mio cammino
se gli occhi che imploravano perdono
smarrirono per sempre la parola
se perso nelle latebre del tempo
io sopravvissi intanto alla mia sorte.
Ma non avrai risposte dal mio cuore
marcito nel più orribile tormento
scarnito dal dolore e dal rimpianto.
E se vorrai restare nel
a masticare comode certezze
non lascerò che pallidi ricordi
a dondolare nella tua memoria.
Sarà un peregrinare del passato
fatto di nebbie fitte e silenziose,
per te che non sai leggere il presente
sarà la lunga notte della vita.
Io resterò al tuo fianco silenzioso
sperando che sia l’anima a parlarti
a riportare in te l’intatta luce
che svela la più dolce verità.
E non aver paura del rancore
è come un fiocco freddo e primordiale,
lontano dal tuo sguardo indifferente,
già pronto a trasformarsi se lo cerchi
nel più potente brivido d’amore.
Ma se il tuo volto dolce e tenebroso
volgesse in fine in altra direzione
a me non resterà che un’ombra d’ombra
a cui affidare il vano mio destino.
Segnalazione di merito poesia in lingua italiana
Renata Sorba – da Asti con la poesia: “Io vivo”
Susy Sacco – da Asti con la poesia: “ Hai smesso di guardarmi”
Lucia D’Abarno – da Roma con la poesia: “A Laurent”
Grazia Dottore – Da Messina con la poesia: “La voce del silenzio”
Anna Maria Riva da Marene (At) con la poesia: “Ascoltare il silenzio”
Rita Graziani da Novara con la poesia: “Momenti sospesi”
Cantone M. Luisa da Trecate (No) con la poesia: “”Silenzio”
Sez. narrativa in lingua italiana
4° clas. –Francesco Gozzo da– Milano con: “Taigeto”
4° clas.- Maria Teresa Montanaro da Canelli (At) con: “Le mani addosso”
4° clas. – Natale Vulcano da Rossano (Cs) con “Per non morire”
4° clas. –Gabriele Andreani da Pesaro con: “Ti ci puoi specchiare”
4° clas – Eugenio Fezza da Genova con: “La ricerca”
4° clas – Piero Sesia da Torino con: “Cavoli e Finocchi”
4°clas. – Francesco Maria Mosconi da Ivrea (To) con: “Racconto di guerra”
3° clas. Ex – Lucia Lo Bianco da Palermo con: “Le donne lo dicono”
incalzante racconto, declinato al femminile, tutto basato sulla corsa, sul dialogo, sulla socialità e sulla condivisione degli sforzi, a volte ingenua, dell’attività sportiva che si trasforma, inaspettatamente, in un dramma. Oltre al valore letterario emerge un grande messaggio sociale sulla violenza sulle donne.
Le Donne lo dicono
“Vorrei fosse la prima volta” pensava e respirava l’aria del mare mentre i piedi volavano leggeri sul terreno. Il Parco della Favorita! Lo aveva lasciato alle spalle e adesso iniziava la discesa che l’avrebbe portata alla spiaggia di Mondello. Era la sua corsa della domenica mattina, il suo allungo come si dice in gergo, la sua voglia di riconciliarsi col mondo. Aveva corso dovunque ma nessun piacere era paragonabile alle prime ore del mattino dentro quel parco immenso. I sentieri pieni di foglie a volte secche ma in altri giorni umidi di rugiada, il calpestio sul morbido sentiero, i piccoli anfratti che ti riportavano indietro nel tempo, a quel passato storico di governo borbonico fatto di domini e violenze.
Le gambe la accompagnavano e quasi non sentiva l’asfalto sotto i piedi nè avvertiva i passi che si avvicinavano sfiorando il terreno con il loro tonfo sordo e quasi impercettibile. “Vai a Mondello?”, si voltò. Non lo conosceva e sì che di corridori ne conosceva tanti. “Sì”, rispose, con la fiducia che esisteva, quasi regola codificata, tra i runners. “Devo fare 30 km stamattina, ho una gara la prossima settimana”, “Per me va bene”, lui “Se vuoi ti faccio compagnia”. Capitava tra runners, ma proprio voleva star sola coi suoi pensieri. “Ho un passo di 5,5 al km”, sperava di allontanarlo “Il tuo mi sembra più veloce”, “Ma no figurati, mi adatto, non ho gare in vista”. Una sensazione, solo una sensazione. Una sensazione di fastidio e disagio. Una sensazione subito allontanata da quella quantità di cellule cerebrali che proprio non vogliono accettare l’idea del sospetto e della diffidenza. Ecco piazza Valdesi. La spiaggia si apre agli occhi. Niente cabine d’inverno solo mare all’orizzonte e goduria per gli occhi e la mente. Aveva corso in ogni parte del mondo ma nessuno spettacolo riusciva ad alleggerirle l’anima come quel golfo che da Valdesi portava fino alla riserva naturale di Capogallo. Lì era cresciuta, lì bambina aveva visto innalzarsi castelli di sabbia e giochi di onde, lì desiderava riversare gli umori e la linfa del suo esile corpo fino ad integrarsi con le vene che scorrevano sotto i suoi piedi. Lì incontrava gli amici ogni domenica mattina, runners come lei e come lei alla ricerca di una simbiosi con la rugiada e l’aria trasparente della domenica mattina per ricaricarsi di nuovi elementi in grado di affrontare l’asprezza delle ore. Quella mattina di febbraio il sole era ancora indeciso nella foschia all’orizzonte ma avrebbe trionfato caldo al ritorno rendendo il percorso più difficile, soprattutto per la lunga salita da affrontare. “Ciao campionessa!”, il suo amico Rodolfo che la salutava le diede coraggio. Rodolfo! Lo incontrava ogni domenica mattina. Settant’anni ma un fisico asciutto da adolescente, scattante ed argentino come l’acqua di una fontanella. Poteva chiedergli compagnia, così da rassicurarla. “Vieni al Faro con noi Rodolfo? Un allungo insieme, dai! La giornata è splendida.” “Non posso, solo 16 km oggi. Devo scappare o mia moglie mi ammazza”, rise forte. La sua risposta non poteva se non confermare il tono ironico con cui molti amici runners maschi parlavano delle proprie mogli, contrarie all’allenamento dei mariti e sempre pronte ad attaccarli se fossero arrivati in ritardo. “Mia moglie si arrabbia tanto, soprattutto la domenica che per lei è sacra”, le aveva confidato spesso Rodolfo, “Non ci vediamo mai durante la settimana secondo lei e quindi almeno la domenica bisogna stare insieme”. La stessa lamentela era venuta spesso anche da altri amici runners, talvolta accompagnata da invettive e improperi nei confronti delle proprie consorti. Non amava quei momenti e non si sentiva in fondo di biasimare quelle povere donne che non condividevano la passione dei propri mariti e desideravano ritagliarsi solo un piccolo spazio all’interno della loro vita. Le donne lo dicono quando hanno bisogno di attenzione, basta ascoltare il suono delle loro parole. Ne aveva parlato spesso durante quelle lunghe corse fatte di confidenze e riflessioni mentre il corpo fendeva l’aria e sconfiggeva gli elementi per sentirsi ancora parte del tutto. Ma gli amici runners maschi sempre maschi sono e come tali… beh! Come tali poco sensibili! Il runner sconosciuto continuava a starle dietro. “Vuoi proprio andare al Faro?”, “Fa parte del mio percorso di allenamento, ma non devi venire se non te la senti!”, “Ma no, figurati”, mentre parlava il respiro di lui cominciava a diventare affannoso. Ma perché non se ne andava? Intanto cosa poteva fare lei? La strada è di tutti. “Vai spesso al Faro?”, “Ogni domenica”. Il Faro! Esisteva forse un percorso più bello? Dopo la pittoresca piazza della frazione di Mondello si seguiva il breve tratto di lungomare che raggiungeva la rocca detta “La Torre”. Lì la costa sbattuta da onde e flutti si faceva rocciosa e frastagliata, in un mare pulito ma dai fondali blu scuro da far paura. Da lì si giungeva al Faro, due chilometri circa di salita mentre magicamente Ustica si profilava all’orizzonte e ci si sentiva protagonisti di un poema omerico. Nessuno avrebbe potuto meravigliarsi se da un momento all’altro fossero spuntati i giganti! Eppure quella domenica il Faro sembrava irraggiungibile e l’atmosfera era carica di una strana tensione che abitava in lei, foriera di strane e inquietanti sensazioni che non aveva mai provato prima. Sembrava quasi che ogni singolo elemento di quel paesaggio marino si fosse coalizzato per comunicare qualcosa attraverso una indecifrabile foresta di simboli, utilizzando codici criptici di impossibile interpretazione. L’aria si era fatta più cupa e la foschia mattutina che velava il pallido sole invernale non si era dipanata come succedeva di solito ma aveva finito per intristire una domenica che sarebbe stata altrimenti a tinte forti, coi colori accesi del cielo e del mare. Le rocce mantenevano la loro atavica e secolare immobilità attendendo un movimento di onde che tardava però ad arrivare. Non riusciva a conciliare il movimento del suo corpo con la staticità del contesto, privato inspiegabilmente dei consueti profumi forti e odori di alghe stagnanti che, come accadeva sempre durante l’inverno, avevano finito per accumularsi a riva. Da piccola sognava di addormentarsi su quel tappeto di residui marini e di nascondervisi dentro alla ricerca di un suo nido. “Ti piace molto questo tratto?”, il runner sconosciuto sembrava averle letto dentro. “Sì, moltissimo. Fa parte di me. E poi è un buon allenamento per la varietà del percorso e..”, “Sì, ma perché ti piace? Ricordi amorosi? Venivi a nasconderti col fidanzato?”. Il tratto in effetti era conosciuto anche per quello, coppiette isolate che andavano in macchina su, fino al cancello e si incontravano per fare l’amore. Anche lei da ragazza si era “infrattata” qualche volta per sbaciucchiarsi col ragazzino di turno. “Ho indovinato, venivi non è vero?” Non le piaceva il suo tono e la confidenza con cui la trattava. E sì che con gli altri runners maschietti si sentiva libera di conversare come voleva. Perché questo strano individuo la faceva sentire così goffa e impacciata? Non era come gli altri. Perché continuava a desiderare che se ne andasse? Aveva sperato che si spompasse e di proposito il suo passo si era fatto più accelerato, più ritmicamente cadenzato ma aveva finito per stancarsi di più e adesso le doleva il ginocchio. Ma il Faro non arrivava mai? Il tratto si era fatto molto isolato dopo la Torre, i soliti runners avevano preferito un altro percorso quella mattina, forse, o semplicemente non erano usciti per allenarsi.
Giunti al cancello con un balzo si lanciò a toccare l’inferriata, gesto scaramantico comune a chi quel tratto lo affrontava settimanalmente durante gli allenamenti. “Qui di solito ci si ferma per ammirare il paesaggio, a volte si vede Ustica”, “Non si vede granchè oggi”, il suo sguardo faceva un po’ paura. Perché lo notava solo ora? “Se vuoi il percorso continua oltre, scendendo da qui sotto. Si può arrivare fino a uno spiazzo e in lontananza c’è “Isola delle Femmine”. “Perché non andiamo insieme? Così mi fai vedere.”, “Sono un po’ stanca, sai e mi fa male il ginocchio e il percorso è sassoso e accidentato.” “Preferisco andare con te lo stesso, così mi indichi la strada”, “Ma guarda che è facile, non ci vuole molto”, “Ho bisogno che venga tu, ho bisogno che ci sia tu”.
Lo scatto arrivò troppo tardi perché lui non riuscisse ad afferrarle il braccio con una forza inaudita e inimmaginabile. La teneva e la trascinava giù per il sentiero e il ginocchio le faceva male sempre più e non sapeva come muovere la gamba. Inciampando e resistendo e urlando e dimenandosi riusciva anche a trovare spazio per piccoli pensieri e sensazioni. Ad esempio perché non era tornata indietro prima, oppure perché non era risalita con Rodolfo o perché avesse continuato a credere di essere libera di decidere cosa fare di sé e del suo corpo in un mondo ancora da inventare. Gridava e si dibatteva contro uno sconosciuto travestito di pelle umana mentre in lontananza si profilava l’immagine della sua cara Isola che secondo la leggenda aveva imprigionato delle donne, delle femmine. Doveva davvero morire con l’Isola muta testimone della sua fine? Urlava no, no e ancora no e in un angolo ancora lucido della sua mente albergava la consapevolezza di come la storia fosse destinata a non cambiare mai, leggenda dopo leggenda, secoli dopo secoli, in un susseguirsi e ciclico ripetersi delle stagioni. Fu il cespuglio di agave sulle rocce a sentire il suo ultimo no e ancora no mentre un enorme sasso la colpiva ripetutamente. Ma era no. Le donne lo dicono.
3° clas. Ex: – Giovanni Macrì da Messina con: “La crisalide: il coraggio di essere se stessi”
Il racconto in prima persona del dramma di una vita vissuta in un corpo sbagliato. Pur trattando un tema scottante rappresenta con grazia una condizione umana particolare, analizzandola con sapienza e garbo. Molto dettagliato nei particolari, assume una vera e propria funzione sociale, soprattutto alla luce degli ultimi eventi di cronaca.
La crisalide: il coraggio di essere se stessi!
Sono nata maschio, ma sin da bambina immaginavo di essere una femmina! Allora c’era nella mia mente solo tanta confusione, più guardavo il mio corpo e più non capivo cosa mi stava succedendo.
Lo guardavo e ogni attimo della mia esistenza mi rendevo conto che quello che stavo passando non era giusto e che bisognava fare qualcosa per cambiarlo. Ogni giorno, guardando in basso al mio ventre o guardandomi allo specchio vedevo ciò che non doveva esserci. Non so quante volte ho pensato di prendere un coltello e tagliarlo via, fuori dalla mia vita!
Durante l’infanzia la mia fantasia, ricorrente era quella che un giorno, svegliandomi al mattino, mi sarebbero spariti come per magia gli organi genitali: pene e testicoli. Crescendo, inorridivo solo al pensiero che potesse crescermi la barba, una delle tante realtà materiali del mio corpo che avrebbe sicuramente deturpato la donna che era in me.
Chiedevo aiuto per essere la donna che mi sentivo di essere, perché se fossi andata avanti così mi sarei sicuramente, e il pensiero era fervido nella mia mente, ammazzata.
Nessuno ascoltava il mio grido di dolore!
A circa venti mesi e con la capacità verbale di esprimere un’opinione sui vestiti, iniziai a chiedere gonne, vestiti e abiti rosa come quelli delle mie sorelle più grandi. I miei genitori pensavano inizialmente di avere un bambino a cui piacevano i vestiti e il rosa. E quando iniziai a disegnare me stessa come una ragazzina con i capelli lunghi e una camicia fluente, lì, iniziarono a porsi delle domande. Già da prima, quando, mi vestivano da maschietto, reagivo avendo delle forti reazioni e dei comportamenti negativi e anche distruttivi. Mi portarono quindi dal medico di famiglia: il mio pediatra. Lui, ignorante in questo campo, si limitò a dire che mi sarebbe passata e questi miei comportamenti erano dettati dal fatto che, essendo il più piccolo di quattro figli, due femmine, un maschio, il più grande e poi… io, mi sentivo trascurata, viste le attenzioni rivolte a loro e reagivo, per lui, “genio senza esperienza”, con questi atteggiamenti particolarmente strani, bizzarri ed eccentrici. Una cosa detta, gettata lì solo per tranquillizzare i miei genitori.
Non ero un bambino, ero una bambina a cui piaceva il colore rosa, urlavo come una bambina, mi comportavo come una bambina, respiravo come una bambina. Non ero un bambino!
Quando ero ragazzina non facevo altro che sognare di portare eleganti abiti femminili su delle stupende scarpe con il tacco. Ahimè, solo sogni! Di nascosto rubavo i vestiti delle mie sorelle e i loro trucchi e quando in casa non c’era nessuno, mi pavoneggiavo davanti lo specchio della mia cameretta realizzando le mie fantasie, godendo di quei momenti rubati, per essere me stessa, correndo di corsa a rimettermi i miei odiati abiti da maschietto e lavarmi il viso quando sentivo che qualcuno rientrava in casa.
Giocavo sempre di nascosto con le loro bambole e con i loro peluches, giochi che avevano dismesso perché più grandi, correndo a riposarli non appena sentivo un rumore sospetto.
All’età di nove anni iniziai a rifiutarmi di tagliarmi i capelli. Averli corti come tutti i ragazzini della mia età era per me un tormento inesprimibile.
Da quando mi sono dichiarata, all’età di tredici anni e mezzo, tutto è cambiato. Dal rapporto con i miei genitori e la mia famiglia, al rapporto con la società ed i miei coetanei.
Sono purtroppo cresciuta in un contesto familiare totalmente privo di affetto per chi era “diverso” dai loro canoni di vita, un contesto dove l’omosessualità veniva considerata addirittura frutto del diavolo ed un male contro cui fermamente lottare e sconfiggere. Ero ostracizzato anche dalla mia stessa famiglia!
I giorni, i mesi passavano ma nulla cambiava, in me c’era sempre l’ossessivo per loro, necessario per me, desiderio di fare emergere la donna che era prigioniera in quel maledetto corpo maschile cui ero nata. Mi portarono all’Ospedale Gaslini di Genova, pensando che si trattasse, la mia, di una malattia da poter curare. Gli attenti medici coadiuvati da un’equipe di validi psicologi, dopo una lunga e attenta analisi del caso, hanno consigliato ai miei genitori di farmi crescere come se fossi una bambina, provando cioè di dare libero sfogo alla mia effettiva natura femminile.
Facendo quindi la corretta diagnosi di “Disforia di genere”, vale a dire la percezione che ogni persona ha di sé e non di un disturbo mentale che andava curato con psicofarmaci.
“Gender Dysphoria” è il termine che gli esperti di medicina usano per descrivere l’angoscia che una persona può provare quando la propria identità di genere non corrisponde al genere cui è stata assegnata alla nascita. E’ l’infelicità persistente, il disagio per l’incongruenza tra il genere che ti viene assegnato, basato sulla tua anatomia alla nascita, rispetto al modo in cui sperimenti il genere al tuo interno.
Loro, puritani e arretrati, di questa diagnosi, peraltro corretta, non ne vollero sapere proprio nulla. Continuarono a obbligarmi a vestirmi con abiti maschili e standomi addosso come farebbe un avvoltoio sulla sua preda, non lasciandomi mai un attimo da solo. Mi castrarono psicologicamente, non permettendomi più di realizzare quelle piccole mie fantasie quando ero sola a casa davanti al mio specchio con i vestiti femminili rubati di nascosto alle mie sorelle. Per anni non ho avuto la mia collocazione in questo mondo, in quanto a scuola ero sotto incessante bersaglio ed a casa dovevo fare i conti con una famiglia che non sapeva capirmi, accettarmi, consolarmi o aiutarmi.
Sin dalle scuole elementari sono iniziati i problemi con i compagni, che mi prendevano in giro perché mi consideravano un “effeminato”. Anche la maestra, ignorante, addirittura fuggiva da me, mi evitava come se fossi un’appestata.
Con gli anni le cose peggioravano sempre più, non andava nulla assolutamente bene, intorno a me v’era il buio. Io non demordevo però, andavo avanti per la mia via, leccandomi le ferite che ogni volta il comportamento di coloro che mi stavano intorno, mi provocavano, cercando di essere minimamente ottimista, anche se era molto difficile e cercando di vedere una minima luce in quel tunnel oscuro che mi circondava.
Venivo derisa per essere troppo magra, per essere femminile, per non amare il calcio, per essere attratta da come vestivano e si truccavano le ragazze, per voler star vicino a loro e non con i miei compagni maschi, venivo derisa perché portavo i capelli lunghi. Loro hanno sempre deriso tutto quello che potevano pensare su di me in termini di genere e sessualità.
Vivevo la mia realtà da… sola!
A scuola sono sempre stata vittima degli attacchi stupidi dei miei compagni, delle loro illazioni, dei loro risolini, delle loro schernite, del loro non voler capire il dramma che stavo vivendo, dalle scuole elementari fino al quinto anno delle superiori. La scuola è stata per me una lenta angoscia e tortura. Sebbene mi abbia fatto soffrire tantissimo, non per questo non studiavo, anzi mi applicavo ancor di più sui libri cercano nella cultura quella consolazione che non arrivava da nessuna parte, eccellendo in ogni materia per salvarmi dal bigottismo ignorante che mi circondava. Le vicende che mi capitavano, gli episodi di bullismo cui sono stata vittima, hanno lentamente formato in me un costante senso di paura, sfiducia e infelicità, una vita di incomprensioni e isolamento.
Non mi vergogno a confessare che ho pensato al suicidio molte volte durante gli anni dai 14 ai 18, ma sono felice di non aver capitolato a quel pensiero estremo.
Ricordo infatti una vessazione nei miei confronti, quando in terza media, poco prima di compiere quattordici anni, dei miei compagni meschini mi tesero un agguato, stretta fra cinque di loro mi strapparono, fra spintoni e risate, i vestiti di dosso. Uno di questi addirittura, con un rossetto, forse di nascosto preso in casa sua, mi tinteggiò prima tutta la faccia, coprendomi di insulti spregevoli e poi, per ultimo, sputandomi addosso, facendomi tornare a casa in lacrime e con gli indumenti tutti laceri. Non ebbi né la forza né il coraggio di denunciarne il fatto agli insegnanti. Ricordo solo il viso di mia madre, ma anche le botte che mi diede mio padre, in uno scatto d’ira, per essere, secondo lui poco virile nei miei atteggiamenti, per essere… un effeminato. Ho dovuto spiegargli nuovamente, con le lacrime agli occhi, non per il dolore che tutti mi provocavano, quello che ero e che io mi sentivo di essere… una donna intrappolata nel corpo di un uomo. Nella loro mente bigotta penso proprio che, forse ancora adesso, non mi accettano e non mi supportano come dovrebbero fare. Le giornate passavano, come uguali passavano gli anni, nulla cambiava!
Faticavo a crearmi delle amicizie e vivevo in un continuo stato di ansia e di depressione.
Tutti mi emarginavano, finanche in famiglia ero appena appena tollerata. Ho vissuto sia l’infanzia e sia l’adolescenza con grande inadeguatezza, non riuscendo mai a comunicare e ad esprimere le mie sensazioni, i miei desideri, ma anche i miei dubbi e le mie paure. Quando dissi in casa che avrei voluto studiare a Bologna, frequentare l’università per conseguire una laurea in “Scienze della comunicazione”, una laurea triennale, furono ben felici di farmi allontanare dal paese in cui vivevo ormai da diciotto anni.
Sicuramente stando lontano dagli occhi dei paesani, il mormorio che aleggiava sulla mia storia si sarebbe notevolmente affievolito. Mi pagavano la retta universitaria e l’affitto di una stanza in un appartamento che dividevo assieme ad altre tre ragazze. Ho imparato cosa significa trans attraverso internet.
Sapevo come mi sentivo, ma non sapevo che esistesse un termine per questo! Fondamentalmente stavo solo provando a confidare a “Google” quello che sentivo. Una lampadina immediatamente esplose nella mia testa, una lampadina che mi ha spiegato tutti i problemi che avevo avuto fino a quel momento. Cominciai quindi a capire la mia vera identità transgender e capire la relazione tra tale identità e il mio orientamento sessuale. Il perché di tutti quei miei comportamenti, etichettati strani o bizzarri che andavano in contrasto con il mio sesso di nascita.Iniziai quindi a documentarmi in maniera seria del mio problema. Iniziai a contattare un centro che tratta proprio questo disagio di sentirsi inadeguati nel corpo cui si è nati.
Non stavo più nella mia pelle, iniziavo a vedere luce nel buio baratro in cui ero precipitata e dove vivevo sola come un’appestata. Iniziai a documentarmi sulla procedura standard per il cambio di sesso che sarebbe durata anni, preceduta da una diagnosi psicologica, di quella stessa diagnosi che mi avevano fatto al “Gaslini”: “Disforia di genere”. Iniziare ad assumere ormoni femminili sotto la guida competente di un medico, quindi la richiesta a un tribunale per autorizzare l’operazione chirurgica e in seguito, a intervento avvenuto, un’altra istanza ad un giudice per cambiare i documenti.
I centri WPATH (World Professional Association for Transgender Health) cui rivolgersi in Italia sono solamente due: uno a Genova, il DiSEM, e l’altro, il D.A.I. – Clinica Medica e Farmacologia Clinica UOC di Endocrinologia situato presso l’Università degli studi di Messina.
Troppo distanti da dove abitavo! Il più idoneo per me era il centro O.N.I.G. a Bologna, al consultorio M.I.T..
Contattai da subito il consultorio M.I.T. e qui mi fissarono un appuntamento e finalmente potetti parlare liberamente dei miei problemi. Persone umane e comprensive dei disagi che noi transgender proviamo ogni attimo della nostra vita. Intrapresi da subito il percorso necessario, tra sedute settimanali con uno psicologo, uno psichiatra e un sessuologo e quindi inizio della terapia ormonale. Una piccola pillola bianca di “Androcur”, per abbassare il livello di testosterone che avevo in circolo. Una ogni giorno per tre mesi!
Notai da subito una diminuzione della rabbia e del nervosismo che c’era in me, forse un effetto placebo, forse la gioia dell’inizio di quel percorso o forse l’azione antagonista di questo sugli ormoni maschili sortisce tale effetto. Sta di fatto che stavo decisamente… meglio! Stavo vivendo una sensazione di calma e serenità interiore. Avevo dato inizio all’avventura più ardua, ma al contempo più emozionante della mia vita!
Già, dopo trenta giorni di cura sentivo le mie forze affievolirsi, iniziavo a mettere su qualche chilo e il grasso si andava a distribuire nei punti dove io volevo ci fosse: fianchi e glutei. La massa muscolare stava diminuendo, anche se ero di mio già magra! Anche la barba e tutti quegli odiosi “pelacci” che mi crescevano sul corpo che deturpavano in maniera orribile la mia femminilità, andavano lentamente a scomparire, andavano a diventare sottili e radi, dando spazio ad un lieve accenno di peluria. Anche se in programma c’era una dermocosmesi, quali laser o elettrocoagulazione e anche qualche ceretta!
Dopo tre mesi, il medico, mi fece implementare la mia pillolina bianca giornaliera con degli estrogeni per via trans-dermica, un cerotto di estradiolo da 0,4 mg/24h. Tutti farmaci questi, purtroppo, epatotossici. Pazienza! Il raggiungimento dello stadio “farfalla” che era in me, necessitava di tanti sacrifici e anche qualche rischio, altrimenti non avrei mai preso il volo!
Naturalmente prima di iniziare la cura ormonale, dovetti fare tutte le analisi del sangue e solo dopo che queste furono nei limiti… ci fu il via dello starter! Il mio corpo ha risposto da subito, sembrava che non aspettasse altro!
Dopo sei mesi di cura già notavo con mia somma gioia che il mio seno era aumentato da una taglia zero ad una seconda taglia. Non stavo più in me, i primi segni di quella femminilità fisica soffocata, stavano pian piano emergendo. Stavano venendo fuori in tutto il loro splendore. Anche la voce aumentava leggermente di grado e fortunatamente non ho mai avuto prominente il “pomo d’Adamo”… almeno quello!
Ricordo che una volta, dopo il diploma, pronta per iscrivermi all’università di Bologna, dovendomi pagare i farmaci per la mia transizione e i viaggi presso il consultorio, quelli se volevo li dovevo pagar io, andai in un famoso locale della città, dove un mio amico, originario del mio stesso paese, lavorava come cameriere. Presentai il mio curriculum scolastico, un curriculum fantastico, massimo dei voti, cento su cento. Andai vestita e truccata da donna. Sono stata subito intervistata sul posto. Il proprietario mi ha fatto un colloquio dicendomi alla fine che mi avrebbe fatto sapere. Qualche esperienza per quanto riguarda il contatto con il pubblico, l’avevo fatta, minima sì, ma l’avevo fatta. Ero riuscita a trovare un lavoretto nel periodo estivo, nelle vacanze scolastiche, in un paese vicino al mio, dove nessuno mi conosceva. A bordo di un vecchio motorino, che era stato di mia sorella, raggiungevo il bar, con un vestiario unisex, ma truccata da donna, facevo le mie otto ore di lavoro per poi fare ritorno a casa, felice come non mai per quella paga settimanale che percepivo. Naturalmente, nessuno si accorse mai del disagio che vivevo! I giorni passarono, anche le settimane! Alla fine ho chiesto al mio amico se sapeva cosa stesse succedendo. Mi ha raccontato la storia di come il titolare della sede aziendale che mi aveva intervistato gli avesse chiesto, una volta andata via, se io fossi un trans e avuta da questi la conferma facendo una faccia schifata, se ne fosse andato redarguendolo di non presentargli più soggetti come me. Lui poverino non aveva avuto il coraggio di riferirmelo, per non addolorarmi ulteriormente. Mi sono sempre trovata davanti a persone che, in modi differenti, mi hanno scartata a priori. Senza conoscermi né dandomi una possibilità.
Non nego che non abbia pensato più e più volte alla prostituzione, identità che però non sentivo mia. Percorso che per fortuna non ho intrapreso! Era meglio avere un diniego tutte le volte che ho provato a cercar di trovare lavoro, che non sentirmi lercia con me stessa. Era proprio la società che sembrava dirmi che l’unica cosa che potevo fare era quella di intraprendere la via della prostituzione per avere qualche soldo in più per le mie necessità e per avere il calore di una persona, perfettamente consapevole del fatto che quello non era amore. La società che mi stava attorno cercava, infatti, in tutti i modi di spingermi violentemente, in maniera rabbiosa ai suoi margini, ai suoi confini più oscuri.
Quindi per poter pagare le cure per il mio processo di transizione, farmaci spese legali e quant’altro, davo qualche ripetizione privata di inglese, conoscendolo abbastanza bene, avendo messo un annuncio all’università. Accanto alla bacheca, dove erano indicati l’inizio dei corsi e gli orari delle lezioni, era appeso un grande tabellone di sughero su cui erano fissati disordinatamente con delle puntine da disegno dei foglietti con i più variegati annunci: studenti che cercavano una camera da condividere, lezioni private per preparare la tesi di laurea e quant’altro. Affissi anche il mio: Ragazza di madre lingua inglese impartisce lezioni private!
Una parte di questo foglietto lo ritagliai in tante striscioline verticali, dove, su ognuna di queste c’era stampato il mio numero di cellulare. Un paio di ragazzi, effettivamente. si sono presentati, dopo qualche giorno, all’indirizzo della mia abitazione in Bologna. Due ragazze di queste, una volta compreso che io fossi una transgender, sono scappate come se avessi avuto la lebbra, senza peraltro pagarmi le prime lezioni che avevo loro già impartito, un altro aveva confuso la mia disforia di genere con la transessualità nella sua accezione più dispregiativa, e pensando che fossi una prostituta aveva pensato bene, per lui, di provarci spudoratamente con me, mettendomi addirittura le mani addosso. Se non fosse stato anche per le mie colleghe di abitazione, venute in mio soccorso sentitami gridare, non so come sarebbe finita. Sono comunque andata avanti con le mie lezioni private! Mi pongo quindi sempre la medesima domanda: “A quanti di noi sono negati i posti di lavoro? Quanti di noi non sono nemmeno presi in considerazione per un lavoro o sono apertamente respinti di lavorare, in compiti per i quali siamo perfettamente qualificati?”
La prima persona cui ho detto di essere transgender è ora una ex ragazza conosciuta al consultorio M.I.T.. Mi è stata di grande aiuto e ho imparato molte competenze da lei, il tipo di cose che le madri insegnano istintivamente alle figlie e che la mia non ha mai minimamente neanche pensato; trucco, acconciatura, vestirsi. Mi ha dato la sicurezza di uscire in pubblico con lei come… una donna. Una parte di me l’amerà sempre per quello che ha fatto per me. Anche perché quel periodo, il processo di transizione, era una fase imbarazzante, sentivo che le persone erano a disagio con il mio aspetto. Non sembravo un uomo, ma non sembravo nemmeno una donna, e la gente non sapeva a volte, come parlarmi. I miei sogni e le mie ambizioni non hanno mai trovato sostegno nei miei familiari. Anzi proprio la mia famiglia è stata quella che ha sempre ha cercato in tutti i modi di ostacolare il mio percorso prima di accettazione del mio orientamento sessuale e poi di ostacolare la mia volontà di diventare donna. Sono stata sempre da sola, tra umiliazioni, discriminazioni, violenze fisiche e psicologiche, tutte atrocità che avrebbero devastato ed annientato chiunque. Ma la mia determinazione, la mia dignità, il mio orgoglio, la mia sensibilità sono state lo stimolo, la risorsa incomparabile per affrontare le tante avversità che la vita ha voluto pormi davanti.
Dopo il periodo canonico di sedute psichiatriche e psicologiche, mesi e mesi di terapia ormonale, tramite un legale del centro ho fatta richiesta ad un giudice che ha emesso una sentenza a che fosse rilasciata l’autorizzazione all’intervento di “vagino-plastica”. Venni indirizzata per questo intervento presso l’ Ospedale “Federico II” di Napoli, dove il medico chirurgo mi spiegò “step by step”, tutto l’intervento dall’inizio alla fine. Di ciò che mi avrebbe fatto, dove avrebbe tagliato e soprattutto cosa avrebbe tolto. Quell’iter, in sintesi, che va dalla demolizione chirurgica del pene alla vagino-plastica, il tutto con immagini perfettamente chiarificatrici al suo computer. Contavo a ritroso, elettrizzata, i giorni che mi separavano da quell’evento che avrebbe trasformato la mia esistenza: l’avrebbe condotta dallo stadio crisalide, allo stadio farfalla. Il sogno di tutta una vita! Era arrivato finalmente il grande giorno! Pervasa da un misto di paura e felicità, vestita di solo un camice di carta verde e coperta da un lenzuolo bianco, ero fatta salire su di una barella e la flebo con il suo deflussore ancora attaccato al mio braccio destro, poggiata sulle mie gambe, mentre due infermiere, dopo avermi praticato una puntura intramuscolare, mi spingevano verso il mio tanto agognato traguardo. Non stavo più nella pelle! Ero quindi accompagnata in uno stato di semi anestesia lungo i tunnel sotterranei dell’ospedale, tunnel dai muri scrostati e permeati di umidità e tappezzati da grosse chiazze nere e verdi di muffa, fino alla sala operatoria. Non ero del tutto addormentata e potevo sentire i cattivi commenti che facevano le due donne sul fatto che stessi per sottopormi al cambio di sesso. Due donne malevoli e bigotte che non potranno mai capire in cento anni della loro squallida vita, il disagio e il malessere che provavo io in quel corpo di uomo che non mi apparteneva. Non dissi nulla, ormai ero abituata ai sorrisini ironici, alle mezze parole, ai commenti sfacciati e alle cattiverie delle persone ignoranti. Arrivati nella stanza che precedeva la sala operatoria fui accolta dall’anestesista, un bell’uomo alto con in testa un cappellino tutto colorato e vestito di un camice azzurrino, che con fare cordiale e molto professionale iniziò a praticare le procedure per addormentarmi tutta e così poter essere sottoposta all’intervento. Dalla barella mi sostennero per salire sul tavolo operatorio e mentre un infermiere vestito di verde speranza mi aiutava, il bell’anestesista faceva scivolare nella flebo che intanto era stata appesa ad un supporto, il liquido che aveva preparato in una siringa. Con voce tranquilla mi disse, chiamandomi “signorina”, di contare da cento all’incontrario. Già quel tono rilassante e quella parola quasi magica mi condussero in un mondo di beatitudine. Cominciai a contare: “Cento, novantanove, novantotto, novantaset…, crollai in un mondo tutto mio di sogni e di estasi.
Lentamente, dopo circa cinque ore, mi svegliai dall’anestesia, l’effetto di questa era quasi al termine, tutta indolenzita al basso ventre, provai di alzarmi, poi, chiudendo gli occhi, posi il medio e l’anulare delle mie mani sulle palpebre come per tenere dentro di me segregato il sogno della mia vita che si era appena realizzato e da cui non volevo assolutamente svegliarmi. Ero diventata a tutti gli effetti una… donna!
La degenza fu, in quell’ospedale, di circa una settimana. Stavo sempre da sola se non quando veniva a trovarmi una mia amica, anch’essa transgender, che da lì a qualche mese avrebbe fatto il mio stesso intervento. Non so se ella veniva per me o soltanto per sapere cosa si provasse, che tipo e intensità di dolori sopportare. Un volto “amico”, al di fuori del personale sanitario, comunque… c’era! Dopo una settimana, il chirurgo, in sala medicazioni, tolte tutte le garze e il catetere che fino a quel momento avevo tenuto, tolti i punti e il tutore morbido che avevo tenuto per tutto quel tempo dentro la mia nuova vagina, mi diede un specchio per darmi la possibilità di vedere i risultati del suo intervento. Ero emozionatissima! Pensavo di vedere da subito un apparato genitale femminile come quelli che si vedono nei libri. Restai insoddisfatta e soprattutto delusa, anche se non c’era più in mezzo alle mie gambe quell’odiato attributo maschile con cui avevo condiviso venti anni della mia vita! Vedevo solamente un orribile orifizio che non aveva nulla a che fare con ciò che mi aspettavo di vedere!
Il paziente e comprensivo uomo, mettendo amorevolmente la sua mano sulla mia spalla, in segno di conforto, mi disse: “Non disperi signorina! Se lo ricorda? Glielo avevo detto che da subito non sarebbe stata come lei desiderava che fosse! Necessita di qualche ritocco futuro! Dalla prossima settimana dovrà usare dei tutori rigidi a diametro variabile per effettuare delle dilatazioni periodiche e soprattutto per evitare la tendenza naturale dei tessuti a ridurre il diametro e la profondità della cavità che ho realizzato! Stia tranquilla! E mi raccomando una perfetta, quasi maniacale, igiene!”.
Quell’intervento non fu, infatti, l’unico al quale dovetti sottopormi. Lo stesso chirurgo a distanza di due mesi, mi consigliò di fare un’ulteriore plastica per armonizzare e completare le mie parti intime. Un piccolo intervento di modellazione cutanea per ottenere, per quanto possibile, un aspetto riconducibile a un perineo femminile.
Io sono stata fortunata, tutto è rientrato nella percentuale degli interventi pienamente riusciti, non invece a qualche altra amica transgender che aveva fatto lo stesso percorso, avendo dovuto subire una “vagino-plastica secondaria” per fallimento del primo intervento o complicanze che ne hanno impedito la funzione.
Successivamente mi sottoposi pure ad un intervento di “mammoplastica additiva”, poiché la sola terapia ormonale, pur avendone influenzato il volume, non mi dava quell’immagine di femminilità soddisfacente per la mia persona. Feci portare la taglia del mio seno, dalla seconda ad una quarta.
Toccavo il cielo con un dito!
Mancava un’ultima cosa per definire nella sua totalità il mio percorso di transizione: il cambio di nome sui documenti.
Il mio legale ha dovuto presentare una nuova richiesta ad un giudice, che una volta verificata (per mezzo di consulenza tecnica d’ufficio) l’avvenuta modifica dal punto di vista anatomico, ha emesso una seconda sentenza che mi avrebbe, finalmente, permesso di ottenere il cambio di identità all’ufficio anagrafe, come pure su tutti i documenti (carta d’identità, patente e passaporto), a eccezione dell’estratto integrale di nascita e del casellario giudiziario.
Una volta venuta fuori dall’ufficio anagrafe guardavo e riguardavo con gioia e con orgoglio la mia carta di identità nuova di zecca: sopra c’è un nome femminile e la dicitura «studentessa». Che buffo, fino al giorno prima c’era scritto «studente» e un nome da uomo!
Ero finalmente diventata ciò che avevo sin da piccolissima desiderato essere esteriormente! Dentro di me la donna che ero sempre stata, era riuscita a venir fuori dal bozzolo in cui era segregata. La prima volta che tornai a casa da donna e vestita da donna, i miei genitori mi dissero che se volevo stare da loro avrei dovuto indossare abiti maschili o che me ne sarei potuta andare via. Non disfeci neanche il borsone che avevo con me. Me ne andai! Da allora non ho mai più messo piede in quella casa dove son nata e cresciuta. Di tanto in tanto parlo al cellulare con mia madre e chatto con i miei fratelli. Niente più!
Una parte di me è anche piuttosto irritata dall’incapacità della mia famiglia di cogliere questa semplice verità: “Sono sempre io indipendentemente da ciò che indosso!”.
Ho potuto provare su di me, come uomini abietti e infami si siano sentiti in diritto di toccare una figura femminile bypassando il mio consenso, di come si fossero comportati in maniera viscida e ambigua come se noi fossimo una razza inferiore non degni degli stessi diritti che hanno loro.
Purtroppo in prima persona, sulla mia pelle ho conosciuto la violenza psicologica. Quella più violenta, che viene messa in atto da un’intera società a discapito di una piccola minoranza. Ho conosciuto anche la discriminazione sessuale. Ho visto con i miei occhi la differenza degli sguardi delle persone su di me da quando indosso abiti femminili e non nascondo il sentirmi una persona transgender.
Ho sempre pensato che per vivere in questa società, non c’era bisogno di essere un…, e non ho mai pensato di NON essere ciò che ero, cioè una… donna. Ora che il mio corpo è quello che doveva essere sin dal primo momento, sin dal mio primo vagito, ora che l’errore commesso da “Madre Natura” è stato corretto, ora che dalla crisalide in cui ero prigioniera è nata la farfalla che mai aveva potuto volare, ora che sono sotto tutti i punti di vista legali e specialmente “fisici” una… DONNA, una cosa è principalmente importante: quando la mattina apro gli occhi, non sento addosso più i giudizi della gente, né percepisco più il loro disgusto. Sento che c’è un altro mondo che mi ruota attorno, un mondo più luminoso che ognuno di noi dovrebbe sentire attorno a sé, soprattutto con la libertà e il coraggio di essere se stessi e di essere amati semplicemente per quello che si è… esseri umani e non scarti della società, mostri da cui fuggire! Oggi vivo, fortunatamente una bella ed intensa storia sentimentale con una ragazzo. “Lui non mi ha mai avvertito biologicamente diversamente da quello che sono adesso, né si è mai posto il problema per il mio passato. Perché io sono stata sempre quello che sono ai suoi occhi!”. A tutte le giovani ragazze transgender prepotentemente dico: “Mai e poi mai permettete a chicchessia di dirvi che cosa potete o non potete fare! Voi non siete al di sotto a nessuno e sicuramente siete esseri umani importanti! Non fatevi schiacciare dalla disperazione e cercate di mai cadere nell’isolamento sociale! Desiderate con tutte voi stesse di trovare la forza di lottare per raggiungere il futuro cui ambite e soprattutto non fatevi annientare da tutti i NO che riceverete!”
2°clas. Pietro Rainero da Acqui Terme (Al) con: “L’uomo che pescava le fiabe”
un racconto in bilico tra la fantasia e la realtà, che si sviluppa poeticamente nel mondo delle fiabe
L’
UOMO CHE PESCAVA FIABE
A Copenaghen c‘è una strada che ha lo strano nome di Hyskenstraede, vicolo di Hysken, e perché si chiama così e cosa significa?
Non lo so, ma so che in questa strada, al numero 46, tra due casette rosse, c’era la bottega del vecchio Niels Peitersen, un pescatore di 72 anni.
E ti assicuro che chi transitava per lo stretto vicolo poteva leggere senza fatica, dipinta in color nero sulla porta di legno, lasciata sempre aperta, la scritta “L’antro di Niels” e se incuriosito sbirciava all’interno, poteva osservare il pescatore intento a rammendare vecchie reti da pesca, ormai in disuso. Il vicolo di Hysken, già lo saprai, si trova nel quartiere di Indre By, e dista poche centinaia di passi dal Nyhavn, il vecchio porto della capitale danese, anche se il nome significa Porto Nuovo.
E tutti i giorni a bordo della sua barca, al calar della notte, il signor Peitersen si allontanava dai colorati edifici che cingevano e facevano da cornice alle acque ed alle banchine del vecchio porto e, remando remando, si dirigeva deciso in direzione della costa svedese.
Giunto poi a metà strada tra la sua Copenaghen e la vicina Malmoe, proprio nel bel mezzo dello stretto dell’Oresund, che divide gli svedesi dai danesi, gettava le reti ed aspettava fiducioso. Di solito i primi chiarori dell’alba trovavano le reti del signor Niels gonfie di pesci di ogni taglia e di ogni peso, impigliati nelle maglie. Ma un bel dì, o meglio una bella notte, si presentò al caro pescatore una inaspettata sorpresa!
Insieme a merluzzi, sogliole e passere di mare vide, sgranando tanto d’occhi, una bottiglia ben sigillata, il cui vetro di color verde lasciava però intravvedere, all’interno, un foglio arrotolato.
Il vecchio Niels, assai incuriosito, tolse il tappo e srotolò la carta arricciata.
Il foglio conteneva un racconto, che narrava di una bellissima principessa sirena, che viveva con la sua famiglia nel suo palazzo reale sul fondo dell’oceano e che incominciava proprio così:
La storia era così bella, ma così bella, che il gentile signor Peitersen si disse, fra sé e sé: “la porterò a casa, e la racconterò a mio nipote Haage ed ai suoi amichetti; a loro piacerà sicuramente molto!”.
E così, quel pomeriggio, il nostro amico pescatore non lavorò a ricucir vecchie reti malandate, ma lesse ad alta voce, nella sua bottega, quella stupenda fiaba. Ed il nipotino Haage, ma anche i suoi amici Mathias, Mikkel, Victor ed Astrid, rimasero incantati a bocca aperta ad ascoltarlo ed a immaginar le avventure di quella sirena, di nome Marina.
Qualche notte più tardi, poi, durante la solita uscita notturna per la pesca, al signor Niels capitò di nuovo di trovare, insieme ai pesci, un foglio accartocciato nascosto in un barile di latta.
Aprendo il foglio, questa volta lesse:
Anche questa narrazione, che parlava di una zia che donava molti dolci al proprio nipote quando questi era piccolo, era bellissima. Sapete cosa fece questa volta il signor Peitersen? Avete indovinato!! Portò i fogli a casa, come la volta prima, e lesse di nuovo la storia ai bimbi del suo quartiere.
E, in quello strano mese di novembre del 1875, una volta o due alla settimana, al signor Peitersen capitò di pescar, insieme a naselli, halibut e gustosi salmoni, di pescar ancora fiabe!
A volte riposte in bottiglie, a volte nascoste in bidoni, a volte accompagnate da bottiglie di vino, ed a volte da barili di olio. Le scovava al largo, nel mezzo dell’Oresund, lo stretto che unisce Mar del Nord e Mar Baltico. Gli capitò, una notte, di trovar impressa, in bella scrittura, questa frase d’inizio:
Come finiva la fiaba?! Sapete che siete curiosi? Comunque ve lo svelo: che il corpo senza vita di una piccola fanciulla viene ritrovato il mattino seguente nella neve, con un sorriso in volto e un mazzetto di fiammiferi spenti in mano. Molto triste, ma molto bella, la storia.
Un’altra volta il nostro pescò un testo che incominciava così:
oppure, era già una notte di dicembre:
una volta il testo diceva:
ed un’altra ancora:
e per altre notti il signor Niels continuò a pescare, nel tratto di mare tra Malmoe e Copenaghen, pesci, grandi e piccoli, bidoni contenenti fiabe e bottiglie di buon vino, e pure bottiglie piene di favole.
Per la gioia incontenibile dei bimbi della capitale danese, che sempre più numerosi riempivano ormai ogni pomeriggio la sua bottega, con gli occhi sognanti e lo stupore nel viso.
Ma un brutto giorno sul finir dell’annata, una sera in cui faceva un freddo terribile; nevicava e cominciava a scendere il buio; era anche l’ultima sera dell’anno, la vigilia di capodanno, il caro, vecchio e gentile signor Niels Peitersen si ammalò e morì.
Morì senza vedere l’anno nuovo; smise quindi di pescar fiabe e di raccontarle. Di narrarle ai bimbi che pensavano che lui le inventasse per loro, che pendevano dalle sue labbra sognando mondi lontani, colorati, fantastici e arcani.
Sapete cosa vi dico? Io credo proprio che da quel giorno, da quel brutto giorno, il quartiere di Indre By sia un poco più povero, credo che Copenaghen sia un po’ più povera.
Anzi che la Danimarca tutta con l’intera Europa, insieme al Mondo, siano più povere.
Giunto a questo punto, caro lettore, ti sarai indubbiamente già posto una domanda: come mai le fiabe di Andersen (le hai riconosciute, vero?), le fiabe del grande scrittore nuotassero nell’acqua del mare, sigillate in bottiglie in attesa di essere catturate dalle reti di un pescatore, lontano lontano, in alto mare, dove l’acqua è azzurra come i petali del più bel fiordaliso, e limpida come il più puro cristallo. Ma è molto profonda, più profonda di ogni scandaglio…..
Già! Come mai le storie intitolate La sirenetta, La Zia Maldidenti, La piccola fiammiferaia, I cigni selvatici, La principessa sul pisello, Il berretto da notte dello scapolo, La goccia d’acqua, Il brutto anatroccolo ed ancora altre ed altre, fossero finite nell’Oresund, annegate nell’acqua indecisa fra il Mar Baltico ed il Mar del Nord.
Ho altro da fare, ma te lo racconto lo stesso!
Devi sapere dunque che Odense, che si trova sull’isola di Fionia e dove stava la casa di Andersen, è lambita dal fiume omonimo, che sfocia poi più a Nord, nelle gelide onde dello stretto di Kattegat.
E, di tanto in tanto, la località è bersagliata da violenti nubifragi che lasciano cader sui tetti delle sue case, ma anche nei giardini e nei vicoli, enormi gocce di acqua, gocce così grandi che, se viste con la lente di ingrandimento, svelano un intero mondo dentro di sé. Sai certamente che cosa è una lente di ingrandimento, una specie di occhiale che rende tutto cento volte più grande di quello che è.
Proprio durante uno di questi allagamenti, dunque, la cantina della casa del signor Andersen, in via Soendergaard al numero 5, si inzuppò d’acqua, acqua che accarezzò le bottiglie nelle quali lo scrittore era uso custodire al riparo di sguardi indiscreti le sue creazioni ancora inedite.
La stessa acqua non stentò poi a convincere quei bidoni, botti o bottiglie che fossero a seguirla, ed andò a depositarsi, dopo qualche giorno e secondo una consueta tradizione, nello stretto di Kattegat.
Ed ecco perché qualche mese dopo, e quando ormai lo scrittore era morto, il signor Niels Peitersen, anzi ad essere precisi il signor Niels Kasper Peitersen, recuperò quelle bellissime storie che se ne stavano chiuse in protettivi bozzoli di vetro, quasi avvertissero di essere troppo preziose per morire, per scomparire per sempre.
Ed è grazie a lui che oggi tutti i bimbi del mondo, e non solo quelli che sono danesi, possono gustare le avvincenti avventure concepite dalla ineguagliabile fantasia del signor Hans Andersen, anzi ad essere pignoli del signor Hans Christian Andersen.
Da dove viene dunque ciascuna delle sue storie?
Da dove viene la storia? Vuoi saperlo? Ci viene dal bidone, quello con dentro le vecchie carte…..
1°clas. Piko Cordis da Ascoli Piceno con: “Lebensraum”
“ Racconto di ambientazione rinascimentale, con bei personaggi e qualche notevole intrusione nel mondo dell’arte e della filosofia, anche senza omicidi si può interessare il pubblico invadendo il campo della finzione storica”
Lebensraum
spazio vitale
Un urlo acuto e inaspettato fece sobbalzare tutti i presenti in aula. Era quello di Severina Scmaglevskaya che non riuscì a contenersi nel fissare dritto negli occhi quegli uomini che le stavano seduti di lato, al banco degli imputati. Un urlo alto che risuonò come una detonazione, percorrendo tutta l’aula 600 dello Justizpalast facendone tremare i vetri delle finestre. Lo udirono in tutta Fürstenstrasse e la sua eco si propagò ovunque nel centro di Norimberga.
Severina aveva gridato per un tempo straordinariamente lungo e mentre la sua memoria era nel passato, nel presente la sua voce aveva finalmente svuotato sé stessa da quella sensazione dell’orrore. Severina, una superstite di Auschwitz, era stata chiamata a deporre contro i 22 gerarchi nazisti, e nel vederli agì senza pensare, mossa dalla repulsione istintiva verso i “demoni del male”. Lo strazio che stava avvertendo era intenso, ma fu proprio quello che non le impedì di fissare i mostri in volto uno a uno. Dopo una pausa fatta di un silenzio pesante e così profondo da sembrare interminabile, con lo sguardo lucido, fisso e rivolto a quei volti senza espressioni; con voce solenne, vibrante, con tono amaro, ma molto decisa, iniziò a parlare.
«In nome di tutte le donne d’Europa, vorrei chiedere ai tedeschi: Dove sono i nostri FIGLI?»
I lineamenti di Severina erano pesanti, contornati da un colorito grigio che rendeva bene l’idea del suo stato di salute ancora molto provato. Del suo essere donna, poco era rimasto, era appena l’ombra di sé stessa. La detenzione del campo di concentramento, gli orrori che dovette sopportare e le atrocità alle quali fu sottoposta erano tutti lì, riuniti nello sdegno della sua espressione e nell’odio sprezzante che finalmente sfogò nella sua domanda. Göring, il delfino designato di Hitler, non le rivolse un solo sguardo arrivando a togliersi gli auricolari dei traduttori per non degnarla neppure dell’ascolto. Gli altri imputati si guardavano le mani, oppure, per evitare d’incrociare sguardi insostenibili, fissavano il soffitto; tra il pubblico e i giornalisti accreditati, la commozione era palpabile e la sensazione di partecipare al grido di dolore era intensa.
Fu la domanda del magistrato militare a Severina a staccare quell’aria greve di turbamento e riportare tutti a un’attenzione desta. «Tra gli imputati seduti, riconosce i suoi carnefici?»
«Sì!», rispose la donna accompagnando la risposta con un cenno della testa. «Ce li può indicare?»
Severina si tirò su la manica della giacca e ne scoprì l’avambraccio sinistro dal quale si poteva ben vedere il numero distintivo tatuatole dai carcerieri. «Guardi, questi eravamo noi tutti: dei numeri. Mi chiede se riconosco i miei carnefici? Ebbene, sì che li riconosco, sono tutti colpevoli allo stesso modo». Il numero a sei cifre spiccava sulla pelle violata dall’indelebile marchio dell’umiliazione umana, fissa tanto sul corpo quanto nell’anima.
«Se la sente di raccontare i fatti che la riguardano?» le chiese il magistrato. Severina si ricompose e accennò ad un sì nuovamente col capo, ma, prima ancora di iniziare a raccontare, abbassò il mento sul petto e iniziò a singhiozzare. «Nel campo della morte, c’era solo una inaudita violenza, non eravamo considerati esseri umani e così, con spregio e senza un briciolo di compassione mi vennero strappati dalle mani i miei figli. Si sono arrogati il diritto di separare le creature dalle loro madri, non una esitazione, non un pentimento, ma solo tanto odio. Ogni mia obiezione veniva punita con uno schiaffo e ogni supplica in nome di una pietà umana era soffocata con la minaccia di una revolverata in faccia. Non ero disperata, ero semplicemente distrutta da un dolore lancinante che aveva una forma inaudita, prendeva tutto il mio essere e lo soffocava, sentivo ogni parte di me come se venisse disintegrata e sventrata. Sentivo i miei bambini urlare, piangevano a dirotto mentre venivano tirati via da me. Fu lì che ho sentito l’odio trasalire e che avvolgeva tutti e ci buttava nella bocca dell’inferno. Il dolore che provai e che ancora vive in me, ecco quello non so descriverlo». Le labbra umide e rugose della donna, sembravano come rozzamente intagliate su di un marmo, però, ogni volta che parlava, queste tremavano vistosamente. «Tutte noi prigioniere eravamo costrette a lavorare all’interno del campo, impegnate in diverse mansioni spesso ripugnanti, lo facevamo con un solo obiettivo, non per sopravvivere, perché s